Cominciamo con leggerezza.
Il conflitto è un aspetto inevitabile, e direi anche imprescindibile, della natura umana.
Questo elemento non solo accompagna l’esperienza di ogni comune mortale nelle sue diverse fasi di vita. Ma genera un’occasione di crescita e sviluppo di sé e delle proprie capacità.
Forse detta così, la situazione non è del tutto chiara.
Provo a riformulare il concetto.
In questa breve fase introduttiva, cerco di spiegare il vasto mondo del conflitto.
Si, perché ne esistono infinite sfumature.
Fino a qui ci siamo.
Il conflitto non è solo un aspetto inevitabile dell’esperienza umana e, in sé, non è un fenomeno negativo. Anzi, tutto il contrario.
Spero di non averti turbato.
Anche in questo caso, penso sia opportuna una piccola precisazione.
Prova a vedere il conflitto come una sorta di laboratorio.
In pratica una specie di spazio in cui poter sperimentare una piccola fetta di noi stessi in relazione con una piccola fetta di un’altra persona.
Anzi, detta più in psicologese: qui noi cerchiamo di far comunicare parti interne ed esterne della nostra identità con parti interne ed esterne dell’identità dell’altra persona.
Probabilmente ti stai chiedendo perché durante il conflitto scatta tutto sto casino.
Come può, il conflitto, essere un spazio di crescita?
Non avere fretta, giovane Padawan. Rischi di perderti tutto il divertimento.
Per spiegare meglio il concetto, provo a dare una forma a queste idee e cerco di parlarti di uno dei luoghi per eccellenza del conflitto: la famiglia.
Una comune e classica famiglia. Non quella del mulino bianco, né quella letta con una vaga cadenza siciliana e accompagnata da una sviolinata di Morricone.
Se adesso stai pensando che, tutto sommato, non è l’unico luogo d’eccellenza.
Ti dico subito che hai ragione.
Alla fine anche la coppia, l’amicizia o l’ambiente di lavoro, possono essere un contesto d’alto pericolo conflittuale.
Giusto. Ma perché complicarsi la vita?
Andiamo per gradi.
Noi tutti, nessuno escluso, siamo inseriti in una sorta di matrioska sistemica (un po’ di sana e pura licenza poetica).
Praticamente siamo inseriti in una serie di sistemi concentrici. Ognuno con le proprie regole.
Qui, nel più piccolo di questi sistemi, troviamo la famiglia.
In pratica una sorta di processo contraddistinto da una serie di continue ridefinizioni e passaggi. Un continuo alternarsi di fasi ed equilibri, da coppia a conviventi, genitori e tanto altro.
Sto parlando, infatti, di una dimensione in cui, per la prima volta, entriamo in contatto con parti esterne a noi. Infatti, lo stare con gli altri, il riconoscere e rispettare le regole e le differenze, qui in famiglia, è all’ordine del giorno.
Proprio in questa bellissima avventura, il conflitto diventa un’esperienza funzionale.
Ovviamente parliamo di contesti in cui il dialogo e l’ascolto sono sufficientemente adeguati.
Infatti, in questi casi, il conflitto permette di entrare in contatto tanto con gli altri, quanto con noi stessi.
Paradossalmente, in contesti funzionali, dal conflitto possiamo imparare anche noi.
Ovviamente, questo aspetto positivo si palesa quando le tensioni e le incomprensioni trovano comunque uno sfogo nello scambio e nel dialogo.
In effetti, rubando un noto aforisma a Lucado, “Il conflitto è inevitabile, ma la lotta è facoltativa”.
Shock!
Penso sia arrivato il momento di sforzarci di normalizzare il conflitto.
E per farlo possiamo cominciare con il chiederci:
Cosa posso fare con questa esperienza? Come la gestisco?
Abbiamo parlato di contesti familiari in cui il dialogo, la curiosità e la scoperta vengono stimolati.
Ma ci sono dimensioni familiari in cui lo scambio reciproco e genuino, basilare per la buona riuscita del conflitto, è condizionato da un insieme di discordanze e fraintendimenti, pensieri pregiudizievoli e distacco emotivo e relazionale.
Ma forse conviene andare per gradi.
Non stiamo qua a parlare di Covid e dei suoi risvolti. Non va più di moda.
Però, per spiegare meglio l’idea che ho in mente, va comunque detto che questa “fantastica” esperienza, irrompendo nella propria quotidianità, ci ha costretto a reinventarci sotto diversi aspetti.
Proprio in questo caso, la famiglia, è diventata un terreno di sperimentazioni e scoperte.
Un flusso in cui la “creatività relazionale” (altro attacco di licenza poetica) e la conflittualità si presentano sotto diverse e nuove forme e intensità, con le loro conseguenze.
In questo contesto, il sottovalutare le discordanze o, peggio ancora, non riconoscere o svalutare le richieste dell’altro, porta con sé uno strascico emotivo non indifferente.
Complichiamo ancora di più i giochi.
Poniamo il caso di una relazione di coppia con figli e descriviamo un contesto in stile “post-apocalittico”.
I partner, tutt’altro che complici-amici, si trovano a vivere in due universi paralleli. La comunicazione, ormai appesantita da incomprensioni e difese, è praticamente insistente.
Tra i due regnano i quattro cavalieri dell’apocalisse (ne ho parlato qui).
I momenti in cui, per sbaglio, i coniugi si incrociano in giro per casa sono colmi di pathos. Un po’ come quelle scene piene di suspance in cui sai che uno dei due ci lascerà le penne.
Ci manca solo un degno contributo musicale per sottolinearne la tensione.
Ecco, proprio in questi scenari, i due coniugi rimarcano la pluralità dei loro ruoli. I confini sono ben delineati e netti.
L’essere genitore, partner e, contemporaneamente, individuo singolo, non è mai stato cosi complicato.
I due provano a giocare tra aspettative, promesse e illusioni. Il tutto nella speranza di mantenere un equilibrio, anche solo apparente.
Il loro essere genitori ne diventa il collante. Le energie, quelle residue, vengono focalizzate sul terzo.
La mancanza di dialogo, però, ne accentua la diversità educativa e genitoriale.
Un accordo nel disaccordo
Eccoti un ulteriore scenario. Dai, si, complichiamoci ancora di più la vita.
Immaginiamo, in un lampo di residua cooperazione, che la coppia genitoriale decide di separarsi.
In questo caso, nonostante l’attenzione il dispendio di energie, un genitore sufficientemente adeguato porrà il focus principale al di là del conflitto. Ovvero concentra, o almeno ci prova, le proprie attenzioni, sul figlio.
Ma questo piccolo dettaglio non è esclusivo dei genitori.
Infatti, nel caso di una separazione, l’interesse principale di un giudice non è tanto incentrato sui singoli coniugi, ma sulla tutela del minore.
Il tutto parte dal principio che quest’ultimo ha diritto al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.
Ovvio Bro!
In realtà non è poi una cosa tanto ovvia e scontata. Parliamo di contesti sufficientemente adeguati e funzionali da un punto di vista affettivo e relazionale.
Ma se volete fare una ricerca e fingervi dei protagonisti di una Serie TV Crime di tutto rispetto vi lasciamo l’articolo da cercare: ex art. 337 quater c.c. (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 14 febbraio 2022, n. 4796).
Nell’augurarvi una buona ricerca torniamo a noi.
Perché proprio dove sussista una crisi della coppia, il Giudice deve valutare il centro di interessi e le relazioni affettive del minore.
Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di preservare, se possibile, il principio della bigenitorialità.
(anche qui, se vi siete divertiti nel fingervi dei protagonisti Crime, vi lascio delle coordinate: Ordinanza n. 24637 del 2021).
Ma che diavoleria sarà mai questa bigenitorialità?
Niente di che.
Semplicemente, e mica tanto, nell’interesse del minore, si cerca di garantire la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio. Il tutto con il fine ultimo di tutelare una continuità affettività, un’assistenza, un’educazione e istruzione di base.
Cioè, praticamente, si cerca di ricostruire una nuova realtà familiare sulla base delle nuove esigenze.
Ovviamente questo bel giochetto prevede un reciproco impegno, su più fronti, da parte dei genitori. Infatti, questi ultimi dovranno far si che il figlio non risenta negativamente della separazione.
Scritto in collaborazione con l’Avv.ta Cecilia Gerbotto
Se ti è piaciuto condividi



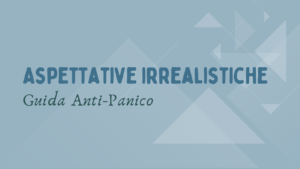

![{"type":"elementor","siteurl":"https://gabrielescapellato.it/wp-json/","elements":[{"id":"8991480","elType":"widget","isInner":false,"isLocked":false,"settings":{"content_width":"full","editor":"L'idea che l'indipendenza sia il segreto della maturità è radicata nella nostra cultura. Pensiamo a James Bond, l'icona dell'uomo coraggioso e insensibile, sempre pronto a salvare il mondo da solo. Ma davvero vogliamo essere come lui?Certo, essere autosufficienti può sembrare attraente, ma la realtà è che una connessione emotiva solida con il partner è ciò che rende le relazioni veramente sane e felici.Immaginate due scenari: in uno, c'è il solito eroe solitario che affronta il mondo da solo. Nell'altro, una coppia qualsiasi in tuta da ginnastica, che affronta le sfide della vita con complicità.Quale dei due vi sembra più... felice?La dipendenza efficace ci insegna che essere in grado di rivolgersi agli altri per ricevere supporto emotivo è un segno di maturità, non di debolezza. La ricerca ha dimostrato che coloro che riescono a fare affidamento sugli altri tendono a essere più forti, più resilienti e, diciamolo, più felici.### Interdipendenza: Il Vero Segreto della Felicità di CoppiaQuando pensiamo all'amore e alle relazioni, spesso cadiamo nella trappola di credere che dobbiamo essere autosufficienti e indipendenti. Questo mito dell'indipendenza ci porta a vedere il bisogno di supporto emotivo come una debolezza. Tuttavia, la verità è ben diversa. La psicologia moderna e la teoria dell'attaccamento ci insegnano che l'interdipendenza è il vero segreto delle relazioni sane e soddisfacenti.### L'Interdipendenza è Forza, non DebolezzaLa capacità di chiedere aiuto e di fare affidamento sugli altri è fondamentale per la nostra salute mentale e il nostro benessere. Le ricerche hanno dimostrato che le persone che riescono a rivolgersi ai propri partner per supporto emotivo sono più forti e resilienti. Questo concetto, noto come \"dipendenza efficace\", sottolinea che la vera maturità risiede nel riconoscere il nostro bisogno di connessione e sostegno.In uno studio condotto da Simpson e collaboratori, 83 coppie sono state osservate per vedere come affrontavano situazioni stressanti. Le donne che si sentivano sicure nella loro relazione erano in grado di condividere la loro tensione con i partner e di chiedere supporto, mentre quelle che negavano i loro bisogni di attaccamento tendevano a chiudersi in se stesse. Gli uomini, dal canto loro, diventavano più supportivi quando si sentivano sicuri della loro relazione, offrendo conforto e calore alle loro compagne.### Chiedere Aiuto è un Segno di Intelligenza EmotivaQuando ci sentiamo sicuri nella nostra relazione, non solo siamo in grado di ottenere e fornire sostegno in modo più efficace, ma anche di affrontare i conflitti in maniera più costruttiva. Studi condotti da Mikulincer e collaboratori hanno dimostrato che le persone con legami sicuri tendono a gestire la rabbia e le difficoltà con maggiore controllo ed empatia. Questo significa che sono meno inclini a reagire in modo aggressivo e più propensi a cercare soluzioni positive ai problemi.Inoltre, queste persone mostrano una maggiore apertura mentale e una curiosità naturale verso nuove esperienze. La sicurezza emotiva fornita da una relazione solida permette loro di essere più flessibili nelle loro credenze e più pronti ad accettare nuove informazioni.### L'Interdipendenza Promuove l'AutonomiaPotrebbe sembrare un paradosso, ma l'interdipendenza promuove anche l'autonomia. Brooke Feeney, in uno studio su 280 coppie, ha riscontrato che coloro che sentivano i propri bisogni emotivi accolti dal partner erano più fiduciosi nella loro capacità di risolvere i problemi da soli. Questo significa che un legame sicuro non solo ci rende più forti insieme, ma ci rende anche più indipendenti nella nostra vita quotidiana.### Conclusione: Abbraccia l'InterdipendenzaIn definitiva, l'idea che dobbiamo essere completamente indipendenti è un mito. Le relazioni felici e funzionali si basano sulla connessione e sul sostegno reciproco. Quindi, la prossima volta che vi sentite sotto pressione, invece di cercare di essere il solito eroe invincibile, provate a cercare conforto nella vostra relazione. Potreste scoprire che, insieme, siete molto più forti di quanto pensavate.Ricordate, chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di intelligenza emotiva e maturità. E sì, anche James Bond avrebbe qualcosa da imparare da questo!","drop_cap":"","text_columns":"","text_columns_tablet":"","text_columns_mobile":"","column_gap":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"column_gap_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"column_gap_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"align":"","align_tablet":"","align_mobile":"","text_color":"","typography_typography":"","typography_font_family":"","typography_font_size":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"typography_font_weight":"","typography_text_transform":"","typography_font_style":"","typography_text_decoration":"","typography_line_height":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"typography_word_spacing":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"typography_word_spacing_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"typography_word_spacing_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"text_shadow_text_shadow_type":"","text_shadow_text_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"color":"rgba(0,0,0,0.3)"},"drop_cap_view":"default","drop_cap_primary_color":"","drop_cap_secondary_color":"","drop_cap_shadow_text_shadow_type":"","drop_cap_shadow_text_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"color":"rgba(0,0,0,0.3)"},"drop_cap_size":{"unit":"px","size":5,"sizes":[]},"drop_cap_space":{"unit":"px","size":10,"sizes":[]},"drop_cap_border_radius":{"unit":"%","size":"","sizes":[]},"drop_cap_border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"drop_cap_typography_typography":"","drop_cap_typography_font_family":"","drop_cap_typography_font_size":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"drop_cap_typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"drop_cap_typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"drop_cap_typography_font_weight":"","drop_cap_typography_text_transform":"","drop_cap_typography_font_style":"","drop_cap_typography_text_decoration":"","drop_cap_typography_line_height":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"drop_cap_typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"drop_cap_typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"drop_cap_typography_word_spacing":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"drop_cap_typography_word_spacing_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"drop_cap_typography_word_spacing_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"_title":"","_margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_element_width":"","_element_width_tablet":"","_element_width_mobile":"","_element_custom_width":{"unit":"%","size":"","sizes":[]},"_element_custom_width_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_element_custom_width_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_flex_align_self":"","_flex_align_self_tablet":"","_flex_align_self_mobile":"","_flex_order":"","_flex_order_tablet":"","_flex_order_mobile":"","_flex_order_custom":"","_flex_order_custom_tablet":"","_flex_order_custom_mobile":"","_flex_size":"","_flex_size_tablet":"","_flex_size_mobile":"","_flex_grow":1,"_flex_grow_tablet":"","_flex_grow_mobile":"","_flex_shrink":1,"_flex_shrink_tablet":"","_flex_shrink_mobile":"","_element_vertical_align":"","_element_vertical_align_tablet":"","_element_vertical_align_mobile":"","_position":"","_offset_orientation_h":"start","_offset_x":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_offset_x_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_x_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_x_end":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_offset_x_end_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_x_end_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_orientation_v":"start","_offset_y":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_offset_y_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_y_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_y_end":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_offset_y_end_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_y_end_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_z_index":"","_z_index_tablet":"","_z_index_mobile":"","_element_id":"","_css_classes":"","e_display_conditions":"","motion_fx_motion_fx_scrolling":"","motion_fx_translateY_effect":"","motion_fx_translateY_direction":"","motion_fx_translateY_speed":{"unit":"px","size":4,"sizes":[]},"motion_fx_translateY_affectedRange":{"unit":"%","size":"","sizes":{"start":0,"end":100}},"motion_fx_translateX_effect":"","motion_fx_translateX_direction":"","motion_fx_translateX_speed":{"unit":"px","size":4,"sizes":[]},"motion_fx_translateX_affectedRange":{"unit":"%","size":"","sizes":{"start":0,"end":100}},"motion_fx_opacity_effect":"","motion_fx_opacity_direction":"out-in","motion_fx_opacity_level":{"unit":"px","size":10,"sizes":[]},"motion_fx_opacity_range":{"unit":"%","size":"","sizes":{"start":20,"end":80}},"motion_fx_blur_effect":"","motion_fx_blur_direction":"out-in","motion_fx_blur_level":{"unit":"px","size":7,"sizes":[]},"motion_fx_blur_range":{"unit":"%","size":"","sizes":{"start":20,"end":80}},"motion_fx_rotateZ_effect":"","motion_fx_rotateZ_direction":"","motion_fx_rotateZ_speed":{"unit":"px","size":1,"sizes":[]},"motion_fx_rotateZ_affectedRange":{"unit":"%","size":"","sizes":{"start":0,"end":100}},"motion_fx_scale_effect":"","motion_fx_scale_direction":"out-in","motion_fx_scale_speed":{"unit":"px","size":4,"sizes":[]},"motion_fx_scale_range":{"unit":"%","size":"","sizes":{"start":20,"end":80}},"motion_fx_transform_origin_x":"center","motion_fx_transform_origin_y":"center","motion_fx_devices":["desktop","tablet","mobile"],"motion_fx_range":"","motion_fx_motion_fx_mouse":"","motion_fx_mouseTrack_effect":"","motion_fx_mouseTrack_direction":"","motion_fx_mouseTrack_speed":{"unit":"px","size":1,"sizes":[]},"motion_fx_tilt_effect":"","motion_fx_tilt_direction":"","motion_fx_tilt_speed":{"unit":"px","size":4,"sizes":[]},"sticky":"","sticky_on":["desktop","tablet","mobile"],"sticky_offset":0,"sticky_offset_tablet":"","sticky_offset_mobile":"","sticky_effects_offset":0,"sticky_effects_offset_tablet":"","sticky_effects_offset_mobile":"","sticky_parent":"","_animation":"","_animation_tablet":"","_animation_mobile":"","animation_duration":"","_animation_delay":"","_transform_rotate_popover":"","_transform_rotateZ_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateZ_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateZ_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotate_3d":"","_transform_rotateX_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateX_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateX_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translate_popover":"","_transform_translateX_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateX_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateX_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_popover":"","_transform_keep_proportions":"yes","_transform_scale_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skew_popover":"","_transform_skewX_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skewX_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewX_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_flipX_effect":"","_transform_flipY_effect":"","_transform_rotate_popover_hover":"","_transform_rotateZ_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateZ_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateZ_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotate_3d_hover":"","_transform_rotateX_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateX_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateX_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translate_popover_hover":"","_transform_translateX_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateX_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateX_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_popover_hover":"","_transform_keep_proportions_hover":"yes","_transform_scale_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skew_popover_hover":"","_transform_skewX_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skewX_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewX_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_flipX_effect_hover":"","_transform_flipY_effect_hover":"","_transform_transition_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"motion_fx_transform_x_anchor_point":"","motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet":"","motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile":"","motion_fx_transform_y_anchor_point":"","motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet":"","motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile":"","_background_background":"","_background_color":"","_background_color_stop":{"unit":"%","size":0,"sizes":[]},"_background_color_stop_tablet":{"unit":"%"},"_background_color_stop_mobile":{"unit":"%"},"_background_color_b":"#f2295b","_background_color_b_stop":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_background_color_b_stop_tablet":{"unit":"%"},"_background_color_b_stop_mobile":{"unit":"%"},"_background_gradient_type":"linear","_background_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180,"sizes":[]},"_background_gradient_angle_tablet":{"unit":"deg"},"_background_gradient_angle_mobile":{"unit":"deg"},"_background_gradient_position":"center center","_background_gradient_position_tablet":"","_background_gradient_position_mobile":"","_background_image":{"url":"","id":"","size":""},"_background_image_tablet":{"url":"","id":"","size":""},"_background_image_mobile":{"url":"","id":"","size":""},"_background_position":"","_background_position_tablet":"","_background_position_mobile":"","_background_xpos":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_xpos_tablet":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_xpos_mobile":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_ypos":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_ypos_tablet":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_ypos_mobile":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_attachment":"","_background_repeat":"","_background_repeat_tablet":"","_background_repeat_mobile":"","_background_size":"","_background_size_tablet":"","_background_size_mobile":"","_background_bg_width":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_background_bg_width_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_background_bg_width_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_background_video_link":"","_background_video_start":"","_background_video_end":"","_background_play_once":"","_background_play_on_mobile":"","_background_privacy_mode":"","_background_video_fallback":{"url":"","id":"","size":""},"_background_slideshow_gallery":[],"_background_slideshow_loop":"yes","_background_slideshow_slide_duration":5000,"_background_slideshow_slide_transition":"fade","_background_slideshow_transition_duration":500,"_background_slideshow_background_size":"","_background_slideshow_background_size_tablet":"","_background_slideshow_background_size_mobile":"","_background_slideshow_background_position":"","_background_slideshow_background_position_tablet":"","_background_slideshow_background_position_mobile":"","_background_slideshow_lazyload":"","_background_slideshow_ken_burns":"","_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction":"in","_background_hover_background":"","_background_hover_color":"","_background_hover_color_stop":{"unit":"%","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_color_stop_tablet":{"unit":"%"},"_background_hover_color_stop_mobile":{"unit":"%"},"_background_hover_color_b":"#f2295b","_background_hover_color_b_stop":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_background_hover_color_b_stop_tablet":{"unit":"%"},"_background_hover_color_b_stop_mobile":{"unit":"%"},"_background_hover_gradient_type":"linear","_background_hover_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180,"sizes":[]},"_background_hover_gradient_angle_tablet":{"unit":"deg"},"_background_hover_gradient_angle_mobile":{"unit":"deg"},"_background_hover_gradient_position":"center center","_background_hover_gradient_position_tablet":"","_background_hover_gradient_position_mobile":"","_background_hover_image":{"url":"","id":"","size":""},"_background_hover_image_tablet":{"url":"","id":"","size":""},"_background_hover_image_mobile":{"url":"","id":"","size":""},"_background_hover_position":"","_background_hover_position_tablet":"","_background_hover_position_mobile":"","_background_hover_xpos":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_xpos_tablet":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_xpos_mobile":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_ypos":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_ypos_tablet":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_ypos_mobile":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_attachment":"","_background_hover_repeat":"","_background_hover_repeat_tablet":"","_background_hover_repeat_mobile":"","_background_hover_size":"","_background_hover_size_tablet":"","_background_hover_size_mobile":"","_background_hover_bg_width":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_background_hover_bg_width_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_background_hover_bg_width_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_background_hover_video_link":"","_background_hover_video_start":"","_background_hover_video_end":"","_background_hover_play_once":"","_background_hover_play_on_mobile":"","_background_hover_privacy_mode":"","_background_hover_video_fallback":{"url":"","id":"","size":""},"_background_hover_slideshow_gallery":[],"_background_hover_slideshow_loop":"yes","_background_hover_slideshow_slide_duration":5000,"_background_hover_slideshow_slide_transition":"fade","_background_hover_slideshow_transition_duration":500,"_background_hover_slideshow_background_size":"","_background_hover_slideshow_background_size_tablet":"","_background_hover_slideshow_background_size_mobile":"","_background_hover_slideshow_background_position":"","_background_hover_slideshow_background_position_tablet":"","_background_hover_slideshow_background_position_mobile":"","_background_hover_slideshow_lazyload":"","_background_hover_slideshow_ken_burns":"","_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction":"in","_background_hover_transition":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_border_border":"","_border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_width_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_width_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_color":"","_border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_box_shadow_type":"","_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"_box_shadow_box_shadow_position":" ","_border_hover_border":"","_border_hover_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_hover_width_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_hover_width_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_hover_color":"","_border_radius_hover":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_hover_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_hover_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_hover_box_shadow_type":"","_box_shadow_hover_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"_box_shadow_hover_box_shadow_position":" ","_border_hover_transition":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_switch":"","_mask_shape":"circle","_mask_image":{"url":"","id":"","size":""},"_mask_notice":"","_mask_size":"contain","_mask_size_tablet":"","_mask_size_mobile":"","_mask_size_scale":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_mask_size_scale_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_size_scale_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_position":"center center","_mask_position_tablet":"","_mask_position_mobile":"","_mask_position_x":{"unit":"%","size":0,"sizes":[]},"_mask_position_x_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_position_x_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_position_y":{"unit":"%","size":0,"sizes":[]},"_mask_position_y_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_position_y_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_repeat":"no-repeat","_mask_repeat_tablet":"","_mask_repeat_mobile":"","hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":"","_attributes":"","custom_css":""},"defaultEditSettings":{"defaultEditRoute":"content"},"elements":[],"widgetType":"text-editor","editSettings":{"defaultEditRoute":"content","panel":{"activeTab":"content","activeSection":"section_editor"}},"htmlCache":""}]}](https://gabrielescapellato.it/wp-content/uploads/2024/07/cover-1-300x169.png)


